Il mondo in cui vive Beau è assurdo e mostruoso. Le strade sono colme di assassini che vanno in giro nudi e uccidono la gente a coltellate, barboni aggressivi che vogliono entrare nelle case o vicini che si lamentano di musica ad alto volume inesistente. Beau va da un analista per affrontare tutto questo ma ciò che lo spaventa di più è dover andare di persona a far visita alla madre che non vede da tempo. Le ha promesso di andarla a trovare ma una serie di incidenti veri o frutto della sua paranoia gli rendono impossibile prendere l’aereo, anche se sa che il non andare avrà delle conseguenze gravissime. Inizia così per Beau un’odissea per tornare a casa che gli farà fare i conti in parte con il suo passato e in parte con l’incapacità di affrontare il mondo e traumi che lo affliggono.

Dopo l’uscita di Nope e The Northman rispettivamente di Jordan Peele e Robert Eggers, entrambi registi che in questi anni hanno fatto parlare di sé nell’ambito del horror d’autore, Beau ha paura era atteso per capire come anche Ari Aster avrebbe affrontato il suo terzo film, dopo l’esordio folgorante di Hereditary e il potente Midsommar. L’autore newyorkese abbandona in questo caso l’horror virando verso il dramma e la commedia, per parlare ciò che in realtà aveva già fatto in precedenza, ovvero quanto possano essere traumatizzanti i rapporti familiari. In questo caso Beau si concentra non tanto sulla famiglia, anche se se ne intravede una parecchio disfunzionale, quanto sul rapporto madre/figlio maschio.

Aster decide di usare il punto di vista di un malato psichiatrico che vede la realtà filtrata dalla malattia. Beau è un uomo sciatto, insicuro che ha paura di attraversare la strada per comprare una bottiglia d’acqua e il mondo gli appare (e ci appare) come la Manhattan in Fuga da New York di Carpenter. Che cosa sia vero e cosa falso a questo punto è irrilevante, e il film inizia un braccio di ferro con lo spettatore che cerca nelle tre ore di durata di mantenere una logica narrativa. Se Beau si muove in uno scenario surrealista è però chiarissimo che l’angoscia che lo tormenta è legata al rapporto castrante con la madre. Già dalla prima sequenza della nascita in soggettiva e poi dalla seduta con lo psichiatra è la mostruosa bugia che lei gli racconta a dare forma a tutte le paure di Beau.

Ci sono veri sprazzi di genio in questo film, come la sequenza in cui la madre racconta al figlio come è morto il padre, ma anche metafore sbandierate, una su tutte il padre-fallo orrorifico. Se nelle opere precedenti di Aster l’elemento fantastico era invece la chiave per un discorso risultante da un’equazione complessa tra i vari elementi della pellicola che andavano dalla storia alla scenografia, il problema di Beau ha paura è di essere fastidiosamente esplicito. La matrice è evidentemente autobiografica (nasce da un corto di 7 minuti, Beau del 2011) il film è infatti scritto, diretto e prodotto proprio da Aster (con A24 ancora una volta alle spalle), ma finisce per essere un pamphlet dilatato e confuso che imbocca a momenti strade alla Gondry. Manca insomma a Beau ha paura la capacità di andare oltre al talento occasionale finendo per risultare un’autoanalisi un po’ fine a se stessa.


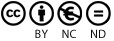

















Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
